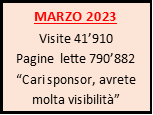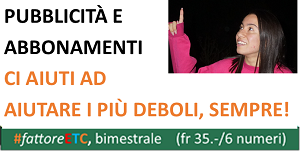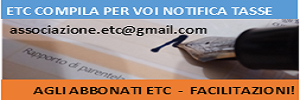E’ il bovino più grande al mondo, dall’ aspetto nobile e dal manto candido e puro.
Quanto è già stato scritto e detto sulla razza Chianina forse tutto, la sua storia, le origini, il rischio di estinzione avvenuto dopo il crollo della mezzadria e l’avvento della meccanizzazione agricola; la riscoperta e la diffusione. Non si è certo dimenticato di elogiarne la bontà e la qualità delle carni, con i capi oggi allevati in conformità agli standard qualitativi dell’IGP “Vitellone bianco dell’Appennino Centrale”, IGP nella quale rientra con altre razze del centro Italia. Probabilmente poco invece si è detto sul territorio di origine di questa razza, la Valdichiana, da cui deriva appunto il nome. Quando agli inizi del novecento il Prof. Ezio Marchi, nato a Bettolle (SI) il 28 giugno 1869, iniziò su base scientifica la prima selezione sulla razza, lo fece tenendo ben conto di quelli che erano gli aspetti sociali, territoriali ed economici della valle; calcolando il tipo di bisogno che l’animale doveva soddisfare.

Forza lavoro nei campi e carne. Oggi la forza lavoro non è più necessaria e la Chianina deve solo, si fa per dire, donare carne di altissima qualità, ma non per questo si deve dimenticare la realtà socio-economica di provenienza dell’animale, la Valdichiana, ricca di risorse umane di prim’ordine e di bellezze naturali. La valle è una pianura limitata da colline, ad eccezione del tratto fra Cortona e Arezzo, dove troviamo monti al quanto aspri e brulli. La razza Chianina ha origini antichissime, secondo Marchi non si escluse, già allora, che i bovini Bos primigenius (Uro selvatico), giunti in Italia con le popolazione indoeuropee contribuirono alla formazione della razza ma, allo stesso tempo, non se ne può accreditare una discendenza diretta ma un’influenza portata su animali domestici. La storia è chiaramente molto lunga è ricca di momenti fondamentali per lo sviluppo della Chianina, non proponibile in poche righe, così come è altrettanto importante la diffusione che in origine abbracciò tutte le zone di pianura e media collina del bacino dell’Arno e nelle provincie di Perugia e Terni; per poi ritrarsi progressivamente in base ai mutamenti socio-economici. Oggi riscontriamo la presenza di capi in Toscana, Umbria e alto Lazio prevalentemente nelle zone collinari. Dal secondo dopoguerra la razza è stata introdotta e diffusa in Australia, Stati Uniti, Canada e Sud America. In Italia è allevata in aziende di medie e piccole dimensioni, per i riproduttori l’allevamento è spesso semibrado e talvolta brado. La stagione di pascolamento dura circa sei mesi, mentre i ricoveri vengono utilizzati nel periodo invernale. L’ingrasso dei vitelli avviene nelle aziende che allevano i riproduttori e in alcuni casi in centri d’ingrasso. L’alimentazione, generalmente basata sull’utilizzo di fieno, silomais e concentrati, viene distribuita meccanicamente così come meccanicamente si opera per la rimozione o aggiunta della lettiera. Dei tagli di carne il più famoso resta la bistecca, la Fiorentina, ma in realtà tutti i tagli sono ottimi anche i meno nobili come il quinto quarto. Un razza bovina che rappresenta una terra, una popolazione e la storia di un pezzo della nostra Italia.
Fabrizio Salce